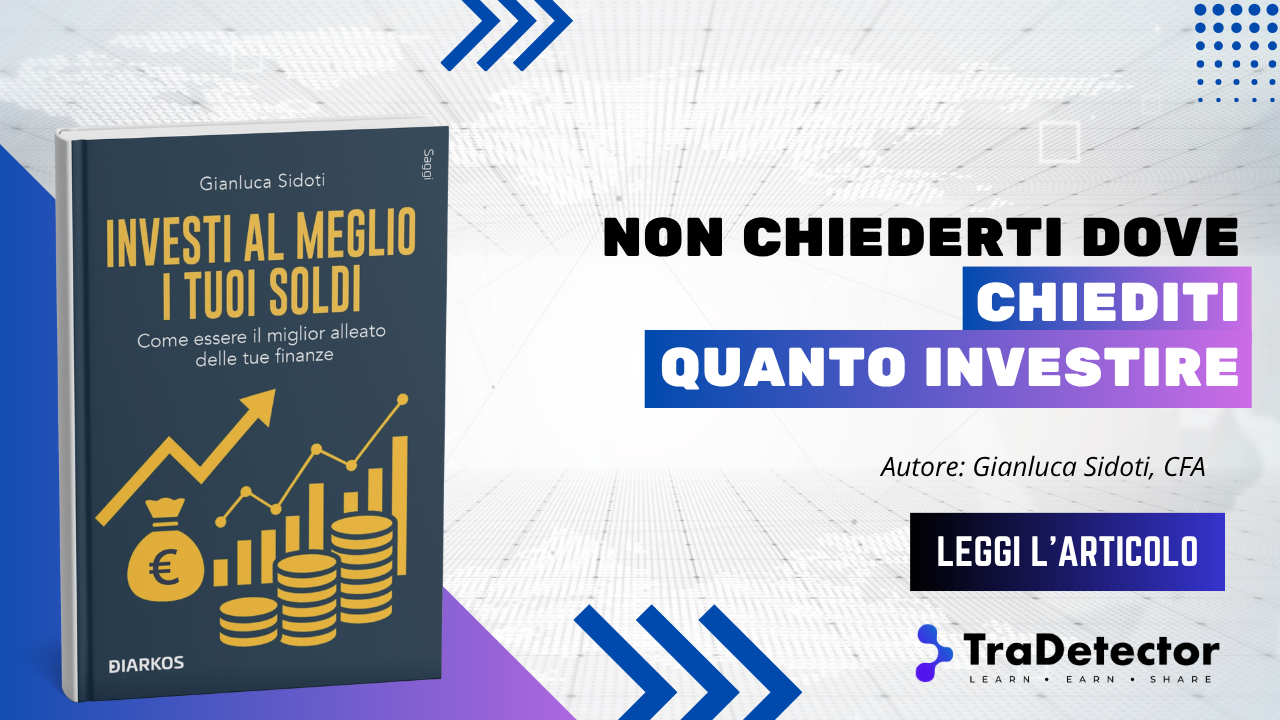
Questo articolo è tratto dall'Introduzione al mio nuovo libro "Investi al meglio i tuoi soldi", edito da Diarkos, e disponibile dal 22 Ottobre 2025 in tutte le librerie e stores online.
Acquistalo su Amazon: https://www.amazon.it/-/en/Gianluca-Sidoti/dp/8836165141/
All’esterno della Grand Central Station di New York si erge una statua imponente di Cornelius Vanderbilt, il magnate ottocentesco che fece fortuna nei trasporti ferroviari e marittimi. Non è lì per caso: fu proprio lui a volere la costruzione di quella che è oggi una delle stazioni più iconiche al mondo. Anche se in parte nascosta dall’architettura invadente del Park Avenue Viaduct, la statua resta visibile nel cuore pulsante di Midtown Manhattan, tra grattacieli e uffici dei moderni titani della finanza.
Alla sua morte, nel 1877, Vanderbilt era l’uomo più ricco del pianeta. Suo figlio maggiore, Billy, ereditò il 95% del patrimonio familiare: ben cento milioni di dollari, una cifra colossale per l’epoca. Eppure, nonostante la fortuna ricevuta, Billy non era stato preparato a gestirla. Cornelius non gli aveva trasmesso né una strategia d’investimento né una visione per la gestione del patrimonio. Il risultato? Nel giro di appena settant’anni, gran parte della ricchezza di famiglia era svanita. Oggi, a quasi centocinquant’anni dalla morte del “Commodoro”, nessuno dei suoi discendenti detiene un patrimonio direttamente collegabile a quella fortuna originaria.
È vero che la famiglia Vanderbilt crebbe rapidamente in termini numerici – più figli, più spese, più dispersione – ma questo non basta a spiegare un simile declino finanziario. Facciamo un semplice esercizio mentale: se Billy avesse investito l’intera somma ereditata in un portafoglio prudente e diversificato, spendendo ogni anno solo il 2% del capitale (tasse incluse), oggi ciascuno dei discendenti ancora in vita avrebbe un patrimonio di oltre cinque miliardi di dollari.
Che cosa è andato storto? Il caso dei Vanderbilt è clamoroso ma non eccezionale. Il fatto che grandi patrimoni si dissolvano in poche generazioni è così frequente che è nato un proverbio universale: “Il nonno costruisce l’impero, il figlio lo mantiene, il nipote lo sperpera”. Basta guardare l’origine dei miliardari di oggi: ben pochi sono eredi di dinastie storiche. Questo ci porta a una verità scomoda ma fondamentale: le famiglie più ricche del passato, nel lungo periodo, non sono riuscite a prendere decisioni coerenti e razionali su come investire e come spendere. Se lo avessero fatto, oggi avremmo molti più miliardari “di stirpe” e meno “nuovi ricchi”.
Per capire l’entità del fenomeno, torniamo al 1900. All’epoca, il censimento degli Stati Uniti registrava circa quattromila milionari, alcuni dei quali con fortune nell’ordine delle centinaia di milioni di dollari. Se anche solo una parte di loro – diciamo una famiglia con 5 milioni di dollari – avesse investito quella somma in un portafoglio azionario ben diversificato e avesse prelevato ogni anno solo una quota sostenibile, oggi quella famiglia avrebbe potuto generare una ricchezza sufficiente per creare almeno sedici famiglie miliardarie.
Estendendo il ragionamento, se un quarto di quei quattromila milionari avesse avuto un patrimonio pari o superiore ai 5 milioni, oggi dovremmo trovare circa 16.000 eredi miliardari legati a quelle fortune del secolo scorso. E questo solo considerando la ricchezza disponibile nel 1900, senza nemmeno includere quella accumulata nei decenni successivi.
Eppure, nel 2025, secondo «Forbes» ci sono poco più di 3000 miliardari nel mondo (di cui oltre 700 solo negli Stati Uniti). Di questi, pochissimi possono far risalire la propria fortuna a un milionario di inizio Novecento. E non bisogna nemmeno tornare così indietro: meno del 10% dei miliardari americani di oggi discende da qualcuno presente nella prima Forbes 400 Rich List del 1982. Anche l’ultimo in classifica di allora – con “appena” 100 milioni di dollari – avrebbe potuto generare almeno quattro famiglie miliardarie oggi.
Sì, alcune famiglie hanno scelto consapevolmente di donare o consumare il proprio patrimonio. Ma si tratta di eccezioni, non della regola. La quasi totale assenza di grandi eredi nell’economia contemporanea non si spiega con la beneficenza o il declino economico, bensì con un dato di fatto: gestire bene il denaro, soprattutto quando è tanto, è difficile. Se persino i più ricchi, con accesso ai migliori consulenti, hanno spesso fallito, che cosa possiamo aspettarci dalla media delle persone?
Un proverbio persiano recita: “È più difficile conservare la ricchezza che crearla”. Ed è proprio questa intuizione controintuitiva ad avermi spinto a scrivere questo libro. L’obiettivo è fornire un metodo chiaro per aiutare le famiglie – non solo quelle più ricche – a prendere decisioni finanziarie migliori, più consapevoli e durature.
Nei prossimi capitoli analizzeremo in dettaglio i principali errori commessi dai cosiddetti “miliardari mancati”, persone che, pur avendo costruito – o ereditato – ingenti fortune, non sono state in grado di accrescerle ulteriormente basandosi su pochi, semplici principi logici: eccesso o scarsità di rischio, spese superiori alle possibilità reali, mancanza di un piano per adattare le abitudini di vita alle oscillazioni del patrimonio. Il vero problema non è stato “scegliere male gli investimenti”, ma non avere un sistema decisionale solido. Queste famiglie si sono lasciate guidare dalle mode del momento, hanno basato il proprio stile di vita su rendimenti sperati ma non garantiti e, spesso, hanno pagato parcelle da capogiro per consulenze mediocri.
Prendiamo un esempio concreto e attuale: Donald Trump. Nell’estate del 2025, secondo le stime di «Forbes», il patrimonio netto dell’ex presidente degli Stati Uniti è di circa 1,5 miliardi di dollari. Una cifra imponente, che potrebbe far pensare a un percorso imprenditoriale straordinario. E in parte è così: Trump è certamente partito da una posizione privilegiata, ma è innegabile che abbia saputo costruire un impero visibile, discusso e redditizio.
Alla morte del padre, nel 2004, Trump ha ereditato l’equivalente di 177 milioni di dollari. In vent’anni, ha moltiplicato quella cifra di oltre sette volte, realizzando un rendimento complessivo del +750%. Una performance impressionante, vero? Eppure, se osserviamo questa storia da un’angolazione diversa – quella dell’investitore razionale – emergono alcune riflessioni interessanti.
Cosa sarebbe successo se, invece di puntare su immobili, hotel e programmi televisivi, Trump avesse semplicemente investito quella somma in un ETF indicizzato sull’S&P 500 e avesse lasciato lavorare il mercato? Oggi il suo patrimonio sarebbe salito a circa 2,5 miliardi di dollari, con un rendimento di oltre il 1300%. Senza costruire grattacieli, senza lanciare reality show, senza candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti d’America.
In altre parole, una strategia di investimento passiva, semplice e ben diversificata avrebbe battuto uno degli imprenditori più famosi del mondo. Non si tratta di sminuire le sue capacità, né di negare il valore dell’imprenditoria, ma di sottolineare un punto cruciale: quando si dispone di capitale, la disciplina e la scelta del veicolo d’investimento contano quanto – se non più – del talento imprenditoriale.
Questa osservazione porta con sé una lezione potente: molti di noi, con gli strumenti giusti, avrebbero potuto fare anche meglio di Donald Trump. Bastava investire in modo coerente e lasciar crescere il capitale nel tempo. D’altronde, negli ultimi cento anni il contesto di mercato è sempre stato favorevole. Il mercato azionario statunitense, infatti, ha registrato un rendimento medio annuo lordo di circa il 10% nell’ultimo secolo. Un milione di dollari investito nel 1900 si sarebbe trasformato in oltre cento miliardi entro il 2024. Le opportunità c’erano. Ciò che è mancata è stata la capacità di gestirle con attenzione.
Il problema è che il mondo della finanza si concentra troppo sul cosa comprare o vendere, e troppo poco sul quanto investire. E invece, le decisioni più importanti ruotano tutte attorno a una parola chiave: dimensionamento. Quanto investire in un’opportunità? Quanto spendere oggi, lasciando spazio per il futuro? Quanto rinviare in tasse? Quanto pagare per proteggersi da rischi estremi? Saper rispondere a queste domande significa trovare il giusto equilibrio tra potenziale guadagno e rischio di perdita.
Perché il dimensionamento è così centrale? Perché anche se fai scelte d’investimento poco brillanti, ma dosi bene l’importo investito, potresti perdere qualcosa, ma senza rovinarti. Al contrario, anche le migliori opportunità possono portare al fallimento se ci punti troppo. Non basta scegliere bene. Serve anche sapere quanto giocarsi.
Imparare a decidere: il vero capitale da costruire
Questa lezione sul "quanto investire" l’ho imparata a mie spese. Avevo sedici anni quando ho iniziato a investire i primi risparmi messi da parte con le paghette. Con il tempo, lavorando e risparmiando con costanza, il mio portafoglio ha cominciato a crescere. In alcuni anni, ho ottenuto rendimenti a tre cifre. Mi sembrava di avere in mano la formula magica della ricchezza. Nel giro di poco tempo avevo moltiplicato per cinque il mio capitale. Ero talmente convinto delle mie capacità che è bastato un solo errore per perdere tutto ciò che avevo costruito. A ventisei anni, poco prima di fondare TraDetector, avevo completamente azzerato i miei risparmi, e con essi tutti i profitti accumulati fino a quel momento.
La mia esperienza, per quanto personale, non è affatto rara. È simile a quella di molti giovani che oggi si avvicinano al trading online o alle criptovalute, affascinati dalla promessa di guadagni rapidi e sostanziosi. Negli ultimi anni, tanti hanno perso migliaia di euro in progetti come FTX, MT Gox, OneCoin, Terra-Luna, e altre iniziative speculative finite male.
Ma forse il caso più emblematico di come anche un solo errore possa azzerare anni di lavoro e studio è quello del fondo LTCM (Long-Term Capital Management), un fondo d’investimento che poteva contare su un team stellare: nel suo consiglio sedevano premi Nobel come Robert Merton e Myron Scholes, protagonisti assoluti della finanza accademica e teorica. Eppure, nonostante la sofisticazione dei modelli matematici su cui si basavano le loro strategie, LTCM fallì clamorosamente.
La vera domanda a cui voglio provare a rispondere, però, è: quanto avrebbero dovuto investire i soci nel fondo? Per molti, la risposta intuitiva è “tutto quello che si può”. Ed è esattamente questo il problema: le risposte intuitive, impulsive, spesso sono anche quelle più sbagliate.
Questo errore non è esclusivo degli hedge fund. Anche gli investitori individuali ne sono vittime, spesso inconsapevoli. Numerosi studi hanno dimostrato che, in media, gli investitori privati ottengono rendimenti inferiori al mercato. Uno dei più noti è quello di Barber e Odean, che ha evidenziato come i trader individuali sottoperformino di circa il 6% annuo rispetto al mercato, soprattutto a causa dell’eccessiva operatività e di un cattivo dimensionamento delle proprie posizioni.
Nel 2013, Victor Haghani – proprio uno dei fondatori di LTCM – insieme a Richard Dewey, ha condotto un esperimento illuminante, pubblicato sul «Journal of Portfolio Management». A sessantuno partecipanti con conoscenze finanziarie avanzate è stato chiesto di scommettere su una moneta virtuale che aveva il 60% di probabilità di cadere su “testa”. Esistevano strategie chiare per massimizzare il guadagno, ma il risultato è stato sorprendente: il 30% dei partecipanti ha perso denaro e il 25% è finito in bancarotta. Anche con un vantaggio statistico evidente, molti hanno sbagliato. Perché? Per un cattivo dimensionamento.
Il tema del “quanto investire” non riguarda solo il mondo finanziario, ma si estende a tutte le grandi decisioni economiche della vita: quanto risparmiare, quanto spendere, quanto destinare alla previdenza. Uno studio congiunto di COVIP e Banca d’Italia ha mostrato che molti italiani versano troppo presto nella previdenza complementare, perdendo – collettivamente – oltre 100 miliardi di euro che avrebbero potuto fruttare molto di più investiti, per esempio, in ETF (fondi d’investimento quotati in borsa). Allo stesso modo, tante persone comprano polizze vita inutili e, nel frattempo, trascurano coperture assicurative realmente importanti.
Le decisioni finanziarie più delicate condividono tre caratteristiche fondamentali:
-
Vanno prese in condizioni di incertezza.
-
Possono avere effetti molto rilevanti sul nostro benessere o sulla nostra felicità.
-
Il loro impatto non è proporzionale alla semplice quantità di denaro coinvolta.
Fin dal Settecento, filosofi, matematici ed economisti hanno cercato di affrontare questi dilemmi in modo sistematico. Daniel Bernoulli, ad esempio, propose il concetto di funzione di utilità per risolvere il cosiddetto “Paradosso di San Pietroburgo” (di cui parleremo più avanti). La sua intuizione – ancora oggi alla base di buona parte della teoria finanziaria – è che il benessere personale cresce con la ricchezza, ma in misura decrescente: ogni euro in più vale meno del precedente. Da qui nasce il concetto, ormai centrale in economia, di massimizzazione dell’utilità attesa.
L’obiettivo delle decisioni finanziarie, quindi, non dovrebbe essere quello di massimizzare il guadagno monetario, ma di massimizzare l’utilità che quel guadagno può offrire, in base alla situazione personale di ciascuno. Questo approccio, divenuto il pilastro della teoria delle decisioni in condizioni di incertezza, è stato perfezionato negli anni Sessanta da Paul Samuelson e Robert C. Merton, i fondatori della disciplina nota come Lifetime consumption and portfolio choice. L’idea è semplice: una persona dovrebbe decidere come investire, risparmiare e spendere nel corso della vita per ottenere il massimo benessere possibile, non il massimo rendimento finanziario.
Tuttavia, queste teorie, per quanto eleganti, sono spesso troppo complesse per trovare applicazione nella vita quotidiana. Questo libro nasce proprio dall’intento di renderle concrete, comprensibili e applicabili anche da chi non è un economista. Non mi interessa solo raccontare cosa la teoria dice che dovremmo fare, ma costruire un ponte tra teoria e pratica.
È vero: il modello della massimizzazione dell’utilità attesa ha dei limiti. Gli esseri umani non sono macchine perfettamente razionali. Spesso, per colpa di bias cognitivi e distorsioni emotive, prendiamo decisioni incoerenti. Ma proprio per questo il modello diventa utile: ci aiuta a riconoscere i nostri errori, a valutarne il costo e a migliorare il processo decisionale.
Un modello, dopotutto, è solo una semplificazione della realtà. Ma è anche uno strumento potente per ragionare con ordine in un contesto complesso. Pensate al concetto di “rendimento a scadenza” per le obbligazioni: ci permette di confrontare titoli con caratteristiche diverse, rendendo semplice ciò che, altrimenti, sarebbe incomparabile. Analogamente, l’utilità attesa ci permette di analizzare scelte finanziarie complesse in modo razionale e personalizzato.
Il primo passo per usare questo approccio nella vita reale è capire la propria funzione di utilità: in altre parole, come varia il nostro benessere al variare della ricchezza. Non è un esercizio difficile. In un sondaggio che ho condotto nel 2022 con una trentina di clienti con grandi patrimoni, tutti sono stati in grado di esprimere, in modo intuitivo, la loro relazione personale tra rischio, ricchezza e soddisfazione.
Il mio obiettivo è guidarti in questo percorso con esempi pratici, rispondendo a domande molto concrete: Quanto conviene investire nella propria azienda? Quando conviene pagare le tasse sulle plusvalenze? Quanto rischio ha senso correre oggi, in vista del futuro? Lo faremo con un po’ di matematica – ma niente che vada oltre le competenze di base delle scuole superiori. Spiegheremo sempre prima la logica, e solo dopo le formule. E te lo dice uno che ha sempre detestato la matematica!
So bene che molti lettori vogliono risposte alla domanda “Cosa comprare?”. Non la ignoreremo. In un mondo così vasto, tra ETF, fondi attivi, azioni, obbligazioni, immobili, hedge fund, private equity, criptovalute e molto altro, un’analisi dei principali strumenti è doverosa. Per questo dedicheremo un’intera sezione alla valutazione di rendimenti e rischi dei diversi investimenti. Ma il cuore di questo libro è altrove: capire quanto investire, quanto rischiare, quanto spendere.
Tutti i concetti che esploreremo sono applicabili con strumenti semplici come un foglio Excel o una calcolatrice. Abbiamo anche creato una serie di tool gratuiti sul nostro sito, www.tradetector.com, per aiutarti a mettere subito in pratica i principi che vedremo insieme. E se hai bisogno di supporto, il nostro team è pronto ad aiutarti o indirizzarti verso le risorse più adatte.
Il libro è diviso in quattro sezioni:
-
Il dimensionamento degli investimenti
-
Come pianificare spesa e investimenti lungo l’intero ciclo di vita
-
Strumenti pratici per migliorare le decisioni finanziarie
-
Alcuni "enigmi" dell’economia comportamentale
Migliorare le proprie decisioni finanziarie non significa solo aumentare il proprio patrimonio: significa migliorare il proprio benessere, aumentare la libertà personale e contribuire a una società più consapevole. Come diceva Benjamin Franklin: «Un investimento nella conoscenza paga i migliori interessi».
Diventa un PRO del denaro e scopri come creare, gestire, proteggere e aumentare la tua ricchezza!






